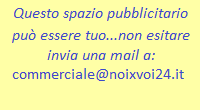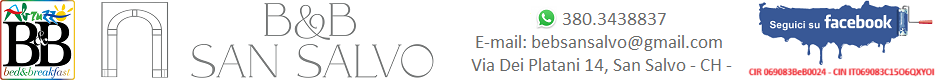Quando certe sere d’estate il cielo è particolarmente limpido chiunque si ferma ad ammirare lo spettacolo luminoso che appare sopra le nostre teste. Qualcuno però, molto prima di noi, ha osservato a lungo e con tanta attenzione la volta celeste.
Il rapporto che gli antichi avevano con gli astri era complesso e articolato e riguardava la vita pratica e materiale, ma anche il settore religioso e filosofico: gli astri erano utilizzati per scandire il tempo, per fare previsioni meteorologiche e per orientarsi; d’altra parte era diffusa l’idea che questi potessero influenzare le vite degli uomini, che avessero a che fare con le divinità e che il cielo inviasse dei segnali da interpretare, alimentando credenze e superstizioni.
Il continuo rapporto degli uomini con la volta celeste portò inevitabilmente alla denominazione e alla catalogazione delle costellazioni, eseguita per la maggior parte dai Greci, popolo di navigatori, e in numero minore dai Romani, che mutuarono i nomi a noi tuttora noti da quelli greci, tramite calchi semantici e prestiti diretti.
I Romani tuttavia diedero alcune denominazioni ancora prima del rapporto con gli Ellenici, utilizzando espressioni che rievocavano l’ambiente in cui vivevano, quello contadino: si prenda il termine “settentrione”, esso deriva dal latino “semptem triones” e indica i sette buoi da lavoro con cui erano identificate le sette stelle dell’Orsa maggiore; per estensione quindi con “settentrione” si passò a designare il Nord, poiché l’Orsa compie il suo movimento attorno alla stella polare, simbolo del Nord per eccellenza.
Un altro criterio per la scelta dei nomi, nel caso dei Greci, riguardava il mito, in quanto certe costellazioni nascevano proprio per ricordare personaggi della mitologia: troviamo quindi Ercole, Orione, Cassiopea, ecc.
Allora da dove trae origine il nome “Canicola”? In latino “canicula” indicava un piccolo cane e in ambito astronomico questo nome faceva riferimento a Sirio, la stella più luminosa della costellazione del Canis Major (Cane Maggiore), che ha la sua levata eliaca (cioè il sorgere di un astro assieme al sole) alla metà di luglio. Il cane che dà il nome alla costellazione era uno dei due cani (l’altro è il Canis Minor) del cacciatore Orione, raffigurato mentre insegue una lepre durante una battuta di caccia.
Il poeta latino Manilio, della cui biografia non si sa praticamente nulla, se non che visse a cavallo tra il I sec. a. C. e il I sec. d. C., nel libro I del poema didascalico “Astronomica”, subito dopo aver descritto la costellazione di Orione, dice: “Subsequitur rapido contenta Canicula cursu/ qua nullum terris uiolentius aduenit astrum/ nec grauius cedit. Nunc horrida frigore surgit/ nunc uacuum soli fulgentem deserit orbem/ sic in utrumque mouet mundum et contraria reddit” (vv. 396-400), e cioè “Segue la Canicola tesa nella sua rapida corsa, della quale nessun astro si leva più violento sulla terra né tramonta più nocivo. Ora sorge in preda ai brividi di freddo, ora lascia lo splendente cielo vuoto al sole, così muove il cielo nell’una o nell’altra direzione e produce effetti contrari”, che significa che la levata e il tramonto eliaco di Sirio si verificano nel periodo più caldo e più freddo dell’anno. Tenendo presente quindi che la Canicola originariamente designava il periodo di caldo massimo che ha inizio alla metà di luglio, si è diffusa l’abitudine di chiamare con questo nome qualsiasi lasso di tempo particolarmente afoso.
Fiorenza Petrocchi